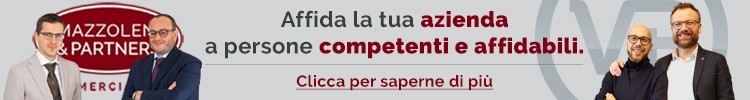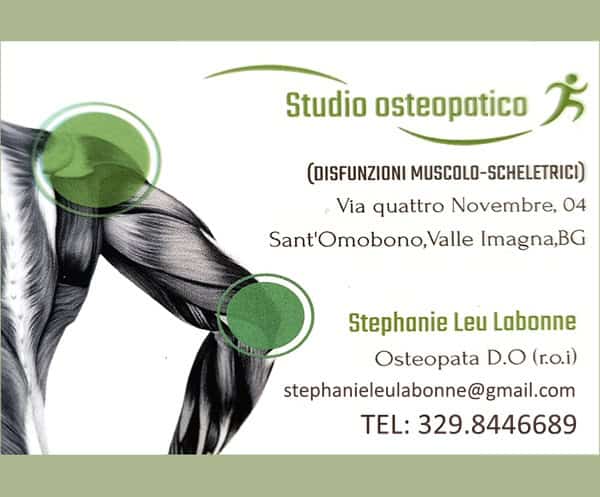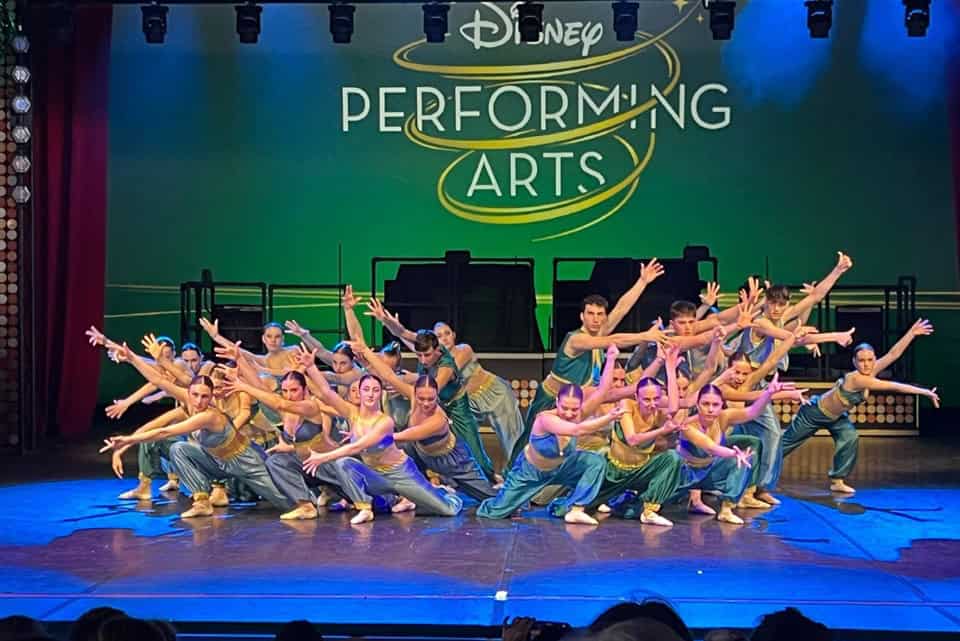In Valle Imagna si tramanda e si rammenta la memoria passata di una delicata tradizione, cioè quella della benedizione delle uova in occasione del Sabato Santo. Un’usanza in grado di unire, nell’attesa del Risorto, uomini e animali: “Pare che anche le galline vi si prest[ino] con così encomiabile fervore che i pollai non [sono] mai così pieni come all’avvicinarsi della Pasqua” (M. Campagnoni e T. Terzi, Folclore Bergamasco, Editrice Cesare Ferrari). Un detto, non a caso, è sopravvissuto fino a oggi, per descrivere l’abnegazione e l’incredibile solerzia dimostrate dal ruspante mondo del pollame valdimagnino: “Catìa polastra chèla che la fa mia ‘l öv a Pasqua” (ibidem).
Le uova, gentilmente e generosamente offerte dalle pollastre nostrane, vengono, oggi come un tempo, accuratamente “cotte sode dentro a certe acque con erbe, scorze di cipolla, fuliggine, ed altri ingredienti” (ibidem) e, successivamente, “portate alla chiesa dentro adorni cestelli” (ibidem). L’attesa cresce finché il prelato “in cotta e stola” (ibidem) non raduna, mediante “un segnale di campana” (ibidem), la comunità intera, procedendo con la benedizione delle uova, eccezion fatta per quelle del Venerdì Santo. Quest’ultime, “segnate di una croce, col carbone” (ibidem), si considerano “già benedette dalla santità del giorno in cui [sono] venute alla luce” (ibidem).
Terminato il liturgico ufficio, le uova dovranno ora pazientare, attendendo il comune destino nel dì di festa, quando verranno “ingerite la mattina della domenica di Pasqua” (ibidem) dopo avere udito recitare, da parte dei vari commensali, “un Gloria-Patri a Gesù risorto” (ibidem). Ogni ovetto verrà selezionato e distribuito con cura, secondo etichette e consuetudini ben disciplinate: “Al regiùr (reggitore) e agli altri uomini di casa [sono] riservate quelle del Venerdì Santo perché siano preservati dalle cadute dagli alberi, specialmente dei gelsi durante la bachicoltura” (ibidem).
Non meno importanti sono tuttavia anche le uova non benedette, consegnate da qualche gallina ritardataria o distratta: verranno dapprima “egualmente colorate e cotte sode” (ibidem) e, in seguito, lasciate ai bambini e ai ragazzi “per giocare a pichèt, […] un gioco nel quale [vince] l’uovo dal guscio più duro” (ibidem).
Tra riti e balocchi, il momento più importante rimane comunque quello detto della Pasquaröla, quando i padrini e le madrine fanno dono di un uovo ai fanciulli di casa, stringendo in un ideale abbraccio intergenerazionale il passato e il futuro della famiglia. Un regalo richiesto esplicitamente dai più piccoli, i quali, spesso, non soddisfatti dall’unico ovetto ricevuto, si fan baldanzosi e temerari, “entra[ndo] in tutte le case con un cestello in mano a domandare la Pasquaröla” (ibidem).
La gioia e la festa diventano contagiose, viaggiando di dimora in dimora, livellando distinzioni sociali e classificazioni vetuste, unendo, nella confusione e nell’eccitazione tipiche della gioventù, i membri della comunità, padri e figli ai piedi delle medesime montagne.