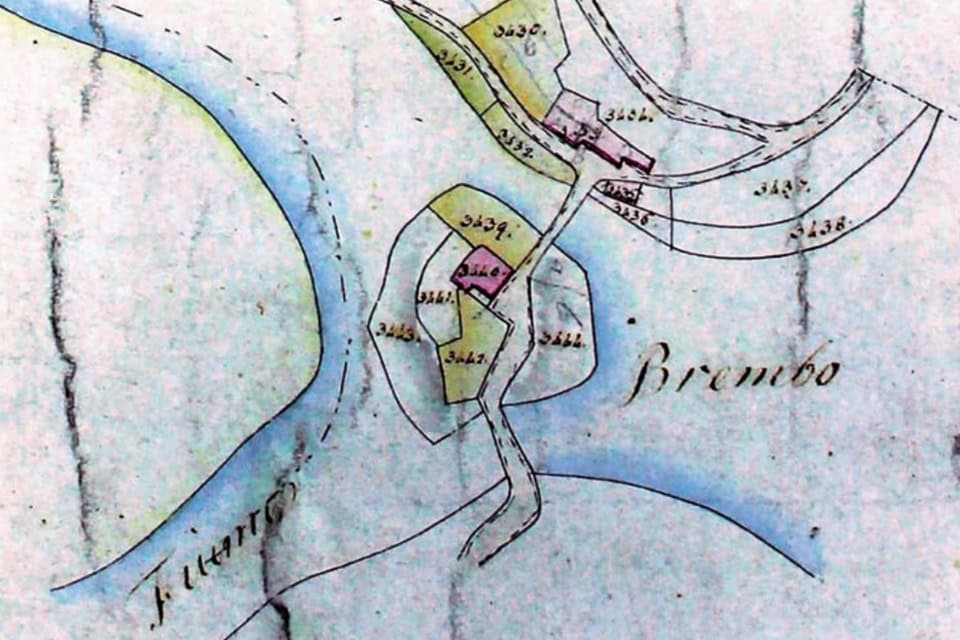Articolo estratto da “Quaderni Brembani n.20” a cura di Arrigo Arrigoni.
Arrigo Arrigoni racconta la sua lontana esperienza di “faméi” in Val Taleggio (così lì si chiamano – probabilmente da famulus, fanciullo – i giovani garzoni d’alpeggio, ma, in genere, anche gli aiutanti adulti di stalla non proprietari). L’impatto di quell’esperienza è scolpito nella sua memoria.
A 11 anni, il giorno dopo aver ottenuto la promozione all’esame d’ammissione alle medie, allora ancora obbligatorio, e in attesa di andare in collegio “a studiare”, i miei mi mandarono a fare “‘l faméi”. Fare il garzone di mandriano ha rappresentato l’avvio al lavoro per generazioni e generazioni di ragazzi di paese spesso di età giovanissima, spesso appartenenti a famiglie non contadine, o a famiglie contadine con pochi capi di bestiame e che non andavano in alpeggio. Naturalmente per i figli dei mandriani l’impegno lavorativo cominciava ancora prima.
Nel 1957 non erano tantissimi i ragazzini che l’estate erano riusciti a evitare di essere mandati a servizio presso qualche famiglia di alpeggiatori, professione allora ancora diffusa anche se zoppicante in un mondo in vorticoso cambiamento. Non ricordo se ad accompagnarmi per un tratto lungo la mulattiera che da Vedeseta sale al Chignolo e al “Prà del Tona”, un alpeggio a prato-pascolo a 1300 m, fosse la mia mamma o se il caso volesse che da “Prà Taè” dove a 16 anni faceva ancora il “faméi” dall’Angelo Arrigoni Marchetù fosse sceso in paese il Ceschi, all’anagrafe
Graziano, uno dei miei fratelli più grandi (Cornelio e Silvano, 19 e 13 anni, quell’anno erano in Francia a fare i boscaioli, Egidio, più piccolo, prenderà il mio posto nel 1958) e così fosse lui a guidarmi fin lassù. Ricordo solo che con me portavo una borsa di tela con dentro quattro indumenti per il cambio, tra cui un “braghett” e delle pezze per avvolgere i piedi che stavano infilati nel mio primo paio di stivali un po’ serio che non avrei alternato con nient’altro per tutta l’estate. Nel cuore la oscura sensazione che stesse finendo la mia fanciullezza.
Su alla cassina del “prà del Tona” mi aspettava il Togno, Antonio Locatelli, il mio “padrù”, che non era ancora sposato, con il quale il mio papà si era accordato con un contratto orale per il mio ingaggio. In cambio del mio servizio, prevedeva oltre a vitto e alloggio, che a mia mamma sembrava già una provvidenza, anche il riconoscimento di 4 mila lire al mese. Con il Togno trovai anche il mio coetaneo e amico Albino Locatelli Bozzet, che più sfortunato di me, non essendo stato mandato a fare l’esame d’ammissione, aveva iniziato il suo lavoro in alpeggio da una decina di giorni e aveva già messo su un’aria da “faméi” esperto.
Il Togno cercò di capire cosa sapessi fare, mi diede le prime indicazioni destinandomi prevalentemente a compiti di “masèra”, cioè alla cucina (avrei imparato, non senza qualche disastro, a fare – tutto rigorosamente sul camino – polenta, minestra, uova strapazzate, burro e cotechini!) e mi mise involontariamente in imbarazzo quando, tra il serio e il faceto e giocando sulle parole e sugli accenti, mi chiese se fossi un “famèi” o un “fa pèsc” (fa meglio o fa peggio). Il mio amico Bozzet mi mostrò la cassina, fatta sostanzialmente di due locali comunicanti posti al piano terra, la baita vera e propria con il semplice focolare nel mezzo e il fumo che se ne andava liberamente in giro fuoriuscendo dal tetto in coppi, un po’ di scorta di rami secchi per il fuoco, il tavolo e una credenza con poche suppellettili e la stanza da letto con tre pagliericci. Tutto molto semplice, ma abbastanza pulito. Sotto la stanza da letto, seminterrata e con la volta a botte, la cantina dove lavorare il latte e ospitare la prima stagionatura degli stracchini. La stalla e il “portech” (penzana) non in aderenza alla cassina ma a una trentina di metri. Per l’acqua (da bere, da cucinare, da sommaria igiene personale) bisognava scendere ai piedi del prato, dove un piccolo “funtanì” in terra battuta raccoglieva uno scolo d’acqua e prelevare con molta circospezione con una “basla” di rame per trasferirla nel secchio.
Per gabinetto andava bene la stalla. Neanche il tempo di guardarmi attorno, di rendermi conto dov’ero, di lanciare uno sguardo laggiù in basso per cercare il campanile del paese e il tetto a “piöde” di quell’altra casa un po’ più in basso che avevo lasciato da poco, che già c’erano novità. Alla baita era arrivato il Guglielmo, uno dei fratelli del Togno: era in partenza per la pianura per andare a prendere i “manzöi a guardia”, le manzette che i grandi fittavoli mandavano ancora d’estate in alpeggio col duplice scopo di irrobustire il bestiame in vista dell’età fertile e di salvare foraggio per l’inverno. Per qualche giorno Gabriele, altro fratello di Togno che con Guglielmo caricava l’alpeggio del “Tai Nöff”, sarebbe rimasto solo e avrebbe avuto bisogno di un aiutante. Il prescelto fui io.
Salutato il mio compagno Albino con Togno mi avviai sul sentiero che, passando dalla Pianchella, un altro alpeggio condotto in affitto dal mio padrone, porta al “Tai Nöff”, nell’alta valle del Bordesiglio. Gabriele, che conoscevo pochissimo, fu gentile con me, mi fece fare una buona merenda di pane burro e zucchero; poi mi portò nel prato dal quale le mucche cominciavano a mandare segnali che avevano finito la ruminata pomeridiana e reclamavano un nuovo pasto di erba fresca. Mi fece vedere il perimetro di prato entro il quale dovevano restare a brucare quel pomeriggio, restò ancora un momento con me mostrandomi come dovevo muovermi e come richiamare le mucche che avessero oltrepassato le linee immaginarie di confine tracciate nell’erba.
Di aiuto c’era anche un cane pastore bergamasco, in realtà un bastardo che obbediva poco anche a lui. Poi mi lasciò solo con le bestie perché doveva andare a “taià l’erba” da servire nella “preséf”, nella mangiatoia, a completamento dei pasti della giornata, e a “fa i mestér” in stalla: spazzarla del letame e preparare la lettiera con del fogliame fresco. Rimasto solo, anche se ero a non più di 150 metri dal complesso baita stalla e portico nel giro di poco tempo mi prese una crescente inquietudine. L’alpeggio del “Tai nöff” è in buona posizione ma al chiuso, da lì non vedi altri alpeggi, solo boschi e, lontano, il Resegone. Il cane se n’era andato un attimo dopo il suo padrone e a nulla erano serviti i miei richiami fatti ora con voce implorante ora con malriusciti tentativi di voce di comando. Nemmeno le mucche davano l’aria di volermi obbedire e sembrava facessero apposta a uscire in continuazione dal “tòcc” loro assegnato.
Per di più il cielo si stava oscurando e da nord scendevano folate di aria fredda. All’aria seguì presto una nebbia dapprima leggera e poi sempre più fitta. Lo Zuccone di Maesimo, la valle del Bordesiglio, la Pianchella, i riferimenti più lontani scomparvero rapidamente dal mio orizzonte visivo, poi anche la baita perse via via il suo contorno consolante e svanì del tutto. Persino le mucche a pochi passi da me diventarono una presenza attutita e quasi evanescente. Mi sentii avvolto in un mondo misterioso e sconosciuto, abbandonato nella più completa solitudine, preda di una angoscia mai provata così forte. All’improvviso gridai.
Foto by Centro Studi Valle Imagna