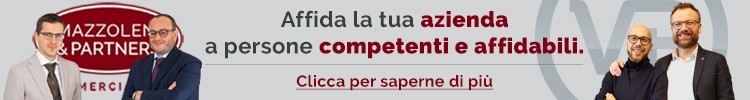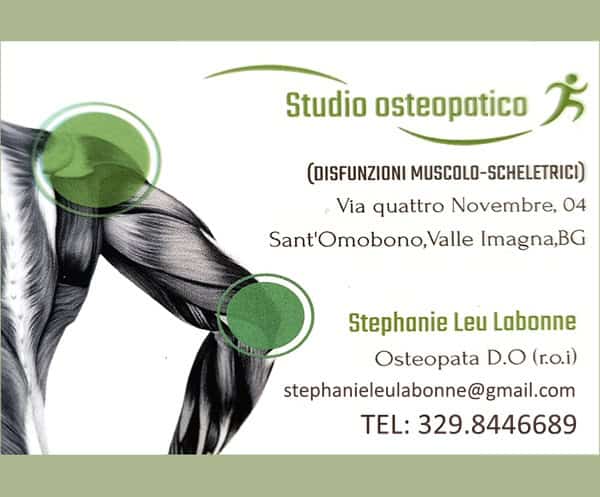La Fondazione Lemine, Soggetto di Rilevanza Regionale per l’ambito Promozione Educativa Culturale, propone per sabato 18 marzo ore 16.00 una visita alla chiesa di San Tomè in occasione del fenomeno luminoso che si verifica nei giorni dell’equinozio primaverile. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 marzo (035-553205 / info@fondazionelemine.eu)
La particolare geometria della rotonda di San Tomè in Almenno San Bartolomeo unita alla sua particolare orientazione astronomica permettono il verificarsi di alcuni spettacolari giochi di luce di grande effetto, provocati dai raggi del Sole e dalla Luna all’interno della chiesa romanica. Durante il Medioevo questi spettacolari effetti luminosi erano considerati di grande effetto ierofanico e furono deliberatamente ed accuratamente calcolati. Nella rotonda di San Tomè il fenomeno più spettacolare si verifica, però, ogni anno in prossimità dei giorni degli equinozi.
Sopra la porta di ingresso, sul lato occidentale della rotonda, esiste una stretta monofora verticale il cui profilo mostra di essere stato deliberatamente spostato e posto fuori asse rispetto all’asse verticale della porta d’accesso alla chiesa. Le accurate misure di posizione e di orientazione eseguite negli ultimi anni in occasione dello studio archeoastronomico della chiesa hanno messo in
evidenza che l’apertura è ulteriormente posta fuori asse rispetto al suo alloggiamento naturale stabilito in fase di edificazione del segmento occidentale del muro perimetrale dell’edificio, questo potrebbe suggerire un aggiustamento eseguito appositamente per far si che il fenomeno solare equinoziale potesse aver luogo.
L’orientazione dell’asse della monofora rispetto alle direzioni astronomiche fondamentali è tale per cui quando il Sole tramonta nei giorni prossimi agli equinozi, esso transita per un particolare punto della Sfera Celeste che corrisponde alla proiezione del vertice superiore della monofora sul cielo.
Questo fa si che la sua luce entri dalla monofora e si proietti all’interno della rotonda con una inclinazione che di 19° la quale corrisponde all’altezza angolare del Sole rispetto all’orizzonte astronomico locale. I raggi solari che passano per la monofora vanno a colpire l’antistante balaustra del matroneo la quale intercetta e rimuove la quasi totalità del fascio di luce, lasciandone solo una sottile porzione libera di propagarsi all’interno della chiesa romanica.

A questo punto, del fascio originale di luce solare, rimane solamente una piccola parte che dopo aver attraversato il presbiterio andrebbe in teoria a proiettarsi sulla base del muro dell’abside, ma essendo presente l’altare collocato in quel luogo durante i restauri ottocenteschi operati dall’ing. Fornoni, il raggio di luce viene intercettato e bloccato in modo tale che sia questo altare ad essere illuminato dal Sole. Durante il suo cammino il fascio di luce solare equinoziale subisce due sezionamenti: il primo da parte del vertice superiore della monofora posta sopra la porta d’ingresso al tempio ed il secondo da parte della balaustra del matroneo.
La sovrapposizione dei due ostacoli lascia libera solo una stretta fenditura attraverso cui la luce solare può passare prima di arrivare a colpire l’altare ottocentesco. Dal punto di vista ottico, l’effetto fisico é quello della “camera oscura”, in cui la luce che proviene da una sorgente estesa, quando passa attraverso un foro molto piccolo proietta su uno schermo l’immagine capovolta della sorgente che è tanto più a fuoco quanto è piccolo il foro: è il fenomeno che avviene nelle macchine fotografiche e che permette di formare l’immagine sulla pellicola o nel caso delle fotocamere digitali, sul sensore CCD.
Sull’altare viene quindi a proiettarsi l’immagine leggermente sfocata del disco solare, che muovendosi gradualmente illumina il tabernacolo al tramonto del terzo giorno precedente l’equinozio di primavera e nel terzo giorno successivo a quello di autunno, dopo di che il Sole, a causa della rotazione della Terra, si sposta gradualmente dalla direzione giusta ed il fenomeno termina.